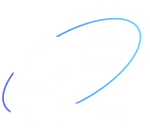Home / Esperienza / Ambrogio Lorenzetti
Ambrogio Lorenzetti

«Famosissimo et singularissimo maestro, fece moltissime opere […] fu perfettissimo maestro, huomo di grande ingegno»: è Ambrogio Lorenzetti, innovatore dei linguaggi, degli stili e dell’iconografia italiana (Lorenzo Ghiberti, Commentarii)
Ambrogio Lorenzetti è senz’altro tra i principali esponenti della Scuola senese e dell’arte Gotica italiana. Attivo nella prima metà del Trecento, in circa trent’anni determina e rinnova lo stile senese con le sue sperimentazioni spaziali e prospettiche. Cariche di significati morali complessi le sue opere invitano gli spettatori ad una riflessione collettiva sui valori della società. Anche per questo Lorenzetti sarà riconosciuto come un maestro dell’allegoria in pittura.
Origini, formazione ed esperienza fiorentina
Poche le notizie certe sulla sua vita: si suppone sia nato attorno al 1290 e la sua presenza è documentata a Siena e a Firenze dal 1319 al 1348. Oggi sappiamo che era fratello minore del pittore Pietro Lorenzetti (1280 ca.-1348 ca.), parentela scoperta solo nell’ottocento, fino ad allora infatti il fratello Pietro era noto come “Pietro Laurati”.
Tali origini famigliari, infatti, erano ignote sia a Ghiberti (1378-1455) sia al Vasari (1511-1574), tra i fondatori della letteratura e della critica d’arte italiana oltre che notevoli artisti.
Il linea con il fratello Pietro, Ambrogio sin da principio adotta un linguaggio vicino alla cultura giottesco fiorentina: le sue figure sono infatti più plastiche e monumentali, meno inclini alla delicatezza e sensibilità senese di Duccio di Buoninsegna (1255 ca.-1318) e di Simone Martini (1284-1344). I suoi lavori si differenziano nettamente da quelli degli artisti a lui contemporanei e conterranei per il particolare uso della linea di contorno che sintetizza le forme e da più peso e concretezza ai soggetti.
Dopo aver lavorato nella zona del Chianti (tra Siena e Firenze), nei primi anni del secolo, Ambrogio è più attivo a Firenze, dove nel 1327 si iscrive all’Arte dei Medici e Speziali, la corporazione che regolamenta l’attività di medici e speziali ma anche di artisti, cartolai e ceraioli. È questa l’Arte alla quali sono iscritti altri grandi protagonisti della storia della cultura Trecentesca, quali Dante Alighieri (1265-1321), Giotto (1265-1337 ca.) e Masaccio (1401-1428).
È durante il periodo fiorentino, grazie alla frequentazione con gli artisti e allo studio delle architetture che il suo linguaggio muta in un forma più delicata e ricca di dettagli, così come possiamo vedere nel Trittico di San Procolo oggi alla Galleria degli Uffizi (1332). Nella tavola colpisce, oltre ai raffinati dettagli delle vesti e dei paramenti sacri, l’umanità dei due protagonisti: il Bambino che stringendo forte il dito della madre, in un gesto intimo e delicato, la osserva incuriosito; e la Madonna che ricambia lo sguardo con un’espressione serena e affettuosa.
Sempre agli Uffizi si trovano altre importanti opere dell’artista come le quattro tavole con Episodi della vita di san Nicola (1332) e la Presentazione al Tempio (1342).


Pittore “pubblico” di Siena
Nel 1338 è nuovamente a Siena, dove è incaricato di interpretare, nella celebre Sala dei Nove del Palazzo Pubblico, le Allegorie del Buono e Cattivo Governo e dei loro effetti in città e in campagna. L’affresco occupa tre delle quattro pareti della stanza: la parete di fondo, opposta alle finestre, e quelle laterali. Il visitatore che si trova dentro la sala si ritrova immerso in una panoramica assai realistica della vita, dentro e fuori le mura. L’opera è lunga circa 35 metri. E’ un’esecuzione difficilissima, ma Ambrogio riesce a concluderla con grande abilità, attraverso il minuzioso ritratto della campagna senese e della vita quotidiana della città, l’artista ci offre diretta testimonianza delle attività e della vita cittadina del primo Trecento. Ancora oggi particolari del dipinto sono la base di studi storici e sociali sulle condizioni di vita e le attività cittadine dei comuni toscani. Nelle due pareti laterali, l’opera rappresenta gli effetti che – un buon o un cattivo governo – determina nella città.
Questo è tra i più celebri esempi nella storia dell’arte italiana di dipinti in cui il contenuto politico e filosofico si fonde con quello religioso. Nelle Allegorie del Buono e Cattivo Governo Ambrogio fa uso di ricche simbologie e personificazioni di valori per trasmettere eloquenti messaggi e ideologie laiche. Tale intento si esplicita anche nel contesto che ospita l’opera: la Sala dei Nove è, infatti, sede delle riunioni del governo senese e le pitture hanno la funzione di insegnamento e di monito.
Gli ultimi anni e la morte
Dopo il successo del Buon Governo, Ambrogio Lorenzetti rimane in città per seguire vari incarichi, tra i quali la già citata Presentazione di Gesù al Tempio (1342) realizzata per l’altare di San Crescenzio del Duomo di Siena e oggi alla Galleria degli Uffizi.
Considerata a buon motivo, una delle maggiori opere dell’artista, qui la sperimentazione spaziale e prospettica è al culmine: la complessa ambientazione architettonica che rappresenta l’interno di una chiesa, è giocata prevalentemente sulle linee prospettiche del ricercato pavimento. L’elegante pala è ricca di preziosi dettagli e il contatto con gli artisti giotteschi è rintracciabile anche dall’uso del chiaroscuro nei corpi dei protagonisti, illuminati da un punto di luce immaginario. Notevoli le innovazioni naturalistiche tipiche dell’artista: anche qui il Bambino muove piedini e si succhia un dito, come a sottolineare il suo aspetto umano e reale.
Il brillante futuro che l’artista ha davanti è stroncato nel 1348 dall’avvento della peste nera: così come il fratello Pietro e tanti altri artisti dell’epoca, Ambrogio Lorenzetti muore infetto dalla peste che sta decimando la popolazione europea. Poco dopo, secondo i documenti a noi giunti, muoiono anch’essi di peste, sua moglie e i suoi tre figli.

Foto di copertina: Storie di San Nicola, 1332 circa, Ambrogio Lorenzetti, Galleria degli Uffizi, Firenze
Galleria
«Famosissimo et singularissimo maestro»: Ambrogio Lorenzetti pittore innovatore dei linguaggi stilistici e dell’iconografia italiana (Lorenzo Ghiberti, Commentarii)
Prodotti correlati
No products were found matching your selection.
Musei correlati
A partire da €9,00
L’antico Palazzo del Podestà di Firenze ospita oggi il Museo Nazionale del Bargello. Dedicato principalmente alla scultura, fa parte dei “Musei del Bargello” insieme alle Cappelle Medicee, ad Orsanmichele, al Palazzo Davanzati e a Casa Martelli.
Tempo medio di percorrenza:
1-2 ore
A partire da €12,00
La nascita della Galleria risale al 1784, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo riorganizza l’antica Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de’ Medici, nella moderna Accademia di Belle Arti. La nuova istituzione doveva ospitare una raccolta di dipinti antichi, moderni e di sculture al fine di facilitare la conoscenza e lo studio ai giovani allievi dell’Accademia.
Tempo medio di percorrenza:
1-2 ore