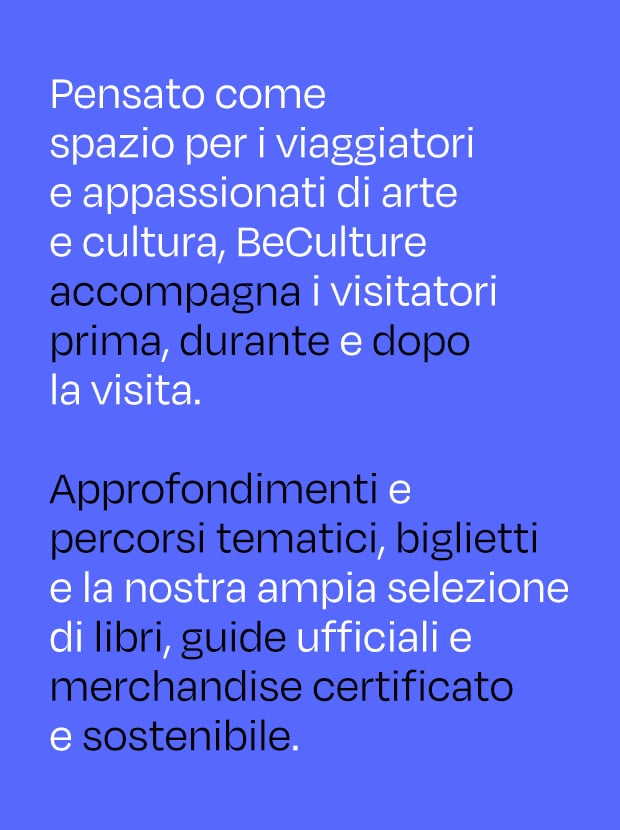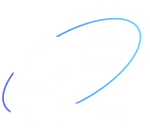Fu ritrovata il 15 novembre 1553 alle porte di Arezzo, mentre si scavava per edificare le nuove mura cittadine. Era arrugginita e sporca, la coda in frammenti, due zampe rotte, occhi e fauci mancanti. Eppure, non c’erano dubbi: era una scultura etrusca. Ed era magnifica.
Fin dal suo rinvenimento, la Chimera di Arezzo ha generato interesse e ammirazione, e persino un certo timore. Conservata oggi all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, non smette di stupire e incantare chi la guarda: scopriamo di più di questo straordinario reperto storico.
Da “Leone di bronzo” a Chimera: il mistero dell’iconografia
Pochi giorni dopo essere stata dissotterrata, la grande scultura bronzea dalle sembianze animali fu portata a Palazzo Vecchio, a Firenze. Il granduca Cosimo I, appassionato di “anticaglie” (come le si chiamava allora), la voleva per sé.
Era chiaro infatti che si trattava di una scultura antica: l’iscrizione in caratteri etruschi “Tinścvil” (ovvero, “offerta”), incisa sulla zampa anteriore destra non lasciava spazio a dubbi. Ma cosa rappresentasse esattamente, non era facile a dirsi.
Molti erano i pezzi mancanti o malmessi al momento del suo ritrovamento: le zampe del lato sinistro erano rotte, la coda ridotta a un moncone, uno dei corni lacunosi. Un mostro, certo, con il corpo leonino e una testa di capra sul dorso percorsa da rivoli di sangue, ma quale mostro?
Mentre gli studiosi di Firenze e Roma, esperti di antichità classiche, si confrontavano alla ricerca di fonti e prove per decifrarne l’identità, il “Leone di bronzo” – così fu battezzato – rimaneva nascosto alla vista del pubblico. Un terribile sospetto si era diffuso. Il corpo principale della bestia ricordava infatti quello del Marzocco, il leone simbolo di Firenze, mentre la testa di capra richiamava il segno zodiacale di Cosimo I, il Capricorno. Entrambi però erano feriti, morenti: che fosse un presagio della fine imminente del granduca?
La smentita arrivò nell’aprile del 1554 quando, posta a confronto con una medaglia romana dall’iconografia simile, fu evidente che si trattava della Chimera, terribile mostro a tre teste della mitologia greca. Da cattivo auspicio la statua bronzea passò ad essere un vero e proprio manifesto politico, simbolo del nemico sconfitto da Cosimo I, moderno Bellerofonte.

Il mito di Bellerofonte e della Chimera
Il mito di Bellerofonte era noto ai dotti rinascimentali grazie alle poesie di Omero ed Esiodo (VIII sec. a.C.), che la descrivono come un mostro tricorpore e sputafuoco: testa e corpo di leone, sul quale si innesta una seconda testa di capra (chimera in greco significa proprio capra) e una coda con testa di serpente. Nata dalla stessa stirpe di Cerbero e dell’Idra di Lerna, la Chimera infestava la Licia, area dell’Anatolia meridionale, terrorizzando la popolazione. Qui viene inviato Bellerofonte in una missione suicida.
Fuggito da Corinto, il giovane si era rifugiato presso la corte del re Preto e della moglie Stenebea, che si innamora di lui. Rifiutata, decide di vendicarsi e convince il marito di essere stata sedotta dal giovane. Preto, intenzionato a punire Bellerofonte senza però ucciderlo e così violare le sacre leggi dell’ospitalità, chiede al ragazzo di recarsi presso la corte di Iobate, suo suocero e sovrano di Xanthos, con la scusa di consegnare una tavoletta. Il messaggio, nascosto, chiedeva a Iobate di assassinare il messaggero. Anch’egli però non vuole venire meno ai suoi obblighi di ospite e così escogita un piano: incarica Bellerofonte di far fuori il temibile mostro a tre teste, convinto che perirà durante lo scontro.
Le cose non vanno però come previsto. Bellerofonte, protetto da Atena, stana la Chimera e, in sella al suo cavallo alato Pegaso, la trafigge con una lancia, uccidendola. Per ringraziarlo, Iobate gli concede in sposa Filonoe, la sua seconda figlia.
Il mito della Chimera e della vittoria di Bellerofonte furono ampiamente rappresentate nell’arte italica ed è probabile che la leggenda cristiana di San Giorgio e il drago derivi proprio da questa antichissima storia pagana.
Tuttavia, nonostante il mito fosse noto anche in epoca rinascimentale, a trarre in dubbio gli intellettuali fiorentini era stata l’assenza della coda serpentiforme, che rendeva incerta l’identità della scultura etrusca. Quella che vediamo oggi, infatti, è stata aggiunta nel XVIII secolo.

Il restauro e la collocazione
Con il passare del tempo, la carica simbolica della Chimera si esaurisce e agli occhi dei Medici passa in secondo piano, almeno fino al 1717 quando, per volontà di Cosimo III, viene collocata nella Galleria degli Uffizi accanto ad altri bronzi antichi.
Quando Luigi Lanzi, nel 1782, decise di riunire qui anche la Minerva di Arezzo, si pose il problema dell’integrità della Chimera che fu risolto di lì a poco. Qualche anno dopo lo scultore e artista Francesco Carradori aggiunse la coda mancante che, per esigenze statiche, si appoggia al corno, parzialmente ricostruito, della capra.
Rimasta agli Uffizi per svariati decenni, la Chimera fu quindi trasferita nel Regio Museo Archeologico di Firenze, attuale Museo Archeologico Nazionale, dove oggi gode di uno spazio esclusivo insieme all’Arringatore, altro bronzo etrusco di notevole fattura.
Un capolavoro senza eguali ma con molti eredi
Non sappiamo con certezza quando e perché fu creata l’opera, ma gli studiosi sono inclini a pensare che sia stata realizzata agli inizi del IV secolo a.C., probabilmente da maestranze etrusche e magno-greche, come dono per un santuario della periferia di Arezzo.
Quel che è certo, è che si tratta di uno degli esempi più grandiosi di scultura antica: merito della sua posa tesa e contratta, segnata dal dolore per le ferite inferte da Bellerofonte. Anche se non vediamo l’eroe che incombe sul suo cavallo alato, lo possiamo facilmente immaginare: il mostro si ritira, quasi si accovaccia sotto la sua minacciosa presenza, l’espressione del volto leonino rabbiosa e sofferente, esasperata dalla mancanza delle fauci.
La capra invece pare già arrendersi all’inevitabile destino, mentre le gocce di sangue colano lungo il suo collo e sul resto del mostruoso corpo con sorprendente realismo.
Sei interessato ad articoli come questo?
Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!
Nonostante la Chimera abbia soggiornato pochissimo nella sua terra d’origine, gli aretini hanno mantenuto un forte legame con la scultura, al punto da sceglierla per lo stemma del quartiere di Porta del Foro. La Chimera è stata inoltre riprodotta in diversi materiali ed esposta in varie zone della città: nel 1933 furono realizzate due copie in bronzo, poste di fronte alla Stazione Ferroviaria e poi fuse per necessità belliche. Negli anni successivi, sono state realizzate altre fusioni, come quella mirabile eseguita nel 2010 dalla Fonderia Artistica Marinelli.
Non sappiamo se la Chimera farà mai ritorno alla sua città natale. Quel che è certo, però, è che è la prova tangibile dello sviluppo culturale e artistico della civiltà etrusca, spesso dimenticato. Se non l’hai mai vista dal vero, una visita al Museo Archeologico fiorentino è d’obbligo!