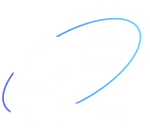Home / Musei / Galleria Colonna
Galleria Colonna

Galleria Colonna
Autentico gioiello del barocco romano, la Galleria Colonna fu commissionata a metà del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna e dal nipote Lorenzo Onofrio. Fu poi inaugurata dal figlio di quest’ultimo, Filippo II, nel 1700. Il progetto originario è dell’architetto Antonio del Grande; successivamente integrato, negli ultimi decenni del 1600, da Gian Lorenzo Bernini, Johan Paul Schor e Carlo Fontana.
Fin dall’inizio la Galleria è stata ideata come grande sala di rappresentanza per celebrare la vittoria nella battaglia di Lepanto del 1571. Il comandante della flotta pontificia, Marcantonio II Colonna, viene raffigurato in vari momenti, su tutta la volta della Sala Grande, nella Sala della Colonna Bellica e in quella dei Paesaggi.
L’affresco della volta sovrastante la Sala della Colonna Bellica è di Giuseppe Bartolomeo Chiari e raffigura la presentazione in cielo di Marcantonio alla Vergine. La sala prende il nome dalla colonna in marmo rosso posta su un piedistallo al centro della sala, che richiama lo stemma della famiglia. I relativi intarsi illustrano scene di vita della Roma antica. Tra i tanti capolavori artistici presenti nella sala, si segnala lo splendido dipinto del Bronzino raffigurante Venere, Cupido e Satiro. Altrettanto interessanti sono i tre grandi dipinti di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio raffiguranti La Notte, sopra il Bronzino, e, sulla parete opposta, L’Aurora, e Venere e Amore.
Sulla breve rampa di scale che scende verso la Sala Grande si trova una palla di cannone giunta esattamente nello stesso punto nel 1849, durante il periodo della Repubblica Romana. La palla fu sparata dal Gianicolo dall’esercito Francese agli ordini del Generale Oudinot, entrato da Porta San Pancrazio per soccorrere Papa Pio IX dagli insorti repubblicani, tra cui Mazzini, Armellini e Saffi, che occuparono per qualche mese il centro storico di Roma.
Ad adornare la volta della Sala Grande il ciclo di affreschi raffiguranti i diversi momenti della battaglia di Lepanto, mentre sulle pareti laterali è possibile ammirare quattro maestose specchiere, dipinte da Mario dei Fiori, Giovanni Stanchi e Carlo Maratta, nonché l’imponente successione di capolavori pittorici ad opera del Guercino, Salvator Rosa, Jacopo Tintoretto, Francesco Salviati, Guido Reni, Giovanni Lanfranco e molti altri. Passeggiando liberamente in questo splendido ambiente si potranno apprezzare i dipinti, le sculture e altri arredi preziosi. Tutto ciò rappresenta il cuore delle collezioni artistiche di famiglia, vincolate dal fidecommesso fin dal XIX secolo quale garanzia per la loro conservazione nel tempo. Tale condizione rende le opere inalienabili e indivisibili, indissolubilmente legate alle mura del Palazzo.
Ove foste interessati a maggiori informazioni sulla famiglia Colonna, il Palazzo e i suoi arredi, è possibile consultare liberamente le pubblicazioni a disposizione del pubblico nei punti dedicati nelle sale Azzurra, Colonna Bellica e Paesaggi.
Oltrepassate le due maestose colonne rivestite in marmo giallo antico, ci si trova nella Sala dei Paesaggi, cosiddetta per i numerosi dipinti a soggetto campestre, opera di Gaspard Dughet. La volta, raffigurante un’allegoria della battaglia di Lepanto, è stata dipinta alla fine del ‘600 da Luca Giordano e Sebastiano Ricci. Il grande scrigno in ebano e avorio, opera dei fratelli tedeschi Steinhart, raffigura scene dall’Antico e dal Nuovo Testamento e, nella parte centrale, riproduce il Giudizio Universale dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina in Vaticano. Sulla parete opposta è collocato uno scrigno in legno di sandalo e pietre dure raffigurante una villa romana dell’epoca.
Procedendo nella visita, si accede alla Sala dell’Apoteosi di Martino V dove è possibile ammirare la grande tela di Benedetto Luti posta al centro del soffitto, raffigurante la presentazione in cielo del Papa di famiglia. In questa sala sono esposti importanti capolavori: Il Mangiafagioli di Annibale Carracci è tra i più famosi e rappresenta il pasto di un contadino del XVI secolo. Quest’opera ha certamente ispirato, dopo tre secoli, pittori impressionisti come Van Gogh e Degas. Sopra questo dipinto è collocata una pregevole tavola del Bronzino, raffigurante la Madonna con il Bambino assopito, S. Anna e S. Giovannino. Alla destra del camino, in alto, il dipinto di Perin del Vaga raffigurante S. Giuliano l’ospitaliero e, in basso, il Ritratto del compositore Adrian Willaert alla spinetta, di Jacopo Tintoretto. Sulla parete centrale, il Tempo rapisce la Bellezza del Cavalier d’Arpino, il Ratto d’Europa di Francesco Albani, S. Girolamo penitente nel deserto del Perugino e la Sacra Famiglia con San Sebastiano, San Girolamo e la Maddalena di Paris Bordone. E ancora, la Madonna Incoronata di Andrea del Sarto, l’Autoritratto con cammeo e la Resurrezione di Lazzaro di Francesco Salviati. Sopra la seicentesca consolle romana, un busto in marmo di Carrara del Cardinale Girolamo I Colonna, committente della Galleria, eseguito da Orfeo Boselli alla metà del 1600. E infine, sulla sinistra, un pregevole dipinto di Jacopo Tintoretto, raffigurante Onofrio Panvinio, uno storico agostiniano molto conosciuto nella sua epoca; sulla destra Il Gentiluomo di Paolo Veronese.
La successiva Sala del Trono è dedicata al Papa di famiglia, Oddone Colonna, eletto Sommo Pontefice l’11 novembre 1417 nella ricorrenza di San Martino, e che per questo motivo scelse il nome di Martino V. Durante il suo pontificato, che durò fino al 1431, Papa Martino V dimorò stabilmente a Palazzo Colonna, che fu pertanto per circa dieci anni Sede Pontificia. Il trono rivolto al ritratto papale era riservato alle visite dei Papi, che fino al 1870 usavano di tanto in tanto visitare i Palazzi delle antiche famiglie del patriziato romano. Ai lati del ritratto del Papa sono collocati due piccoli ritratti raffiguranti Marcantonio II Colonna, trionfatore a Lepanto, e sua moglie Felice Orsini, ad opera di Scipione Pulzone; sulla stessa parete si trovano anche i due dipinti più antichi della Collezione, la Madonna con Angeli di Stefano da Verona, del XIV secolo, e la Crocifissione di Jacopo Avanzi, anch’essa del 1300.
Nella Sala dell’Arazzo è possibile ammirare il grande arazzo seicentesco di manifattura italiana raffigurante La Regina Artemisia esamina il progetto per la tomba del marito Mausolo. Inoltre, molti dipinti di squisita fattura, tra cui La strage degli innocenti di Jacopo del Sellaio, La riconciliazione di Esaù con Giacobbe di Peter Paul Rubens e bottega, e l’Ecce homo di Francesco Bassano il Giovane.
La successiva Sala Gialla, o sala d’ingresso all’Appartamento Galleria dall’interno del Palazzo, mostra affreschi parietali eseguiti dai fratelli Giuseppe e Stefano Pozzi, autori del corredo figurale, e da Giovanni Angeloni, per i paesaggi ed ornamenti, e furono realizzati all’incirca nella metà degli anni Cinquanta del Settecento. Essi rappresentano vedute ideali di ville, con scenografici effetti a trompe-l’oeil, come le due ghirlande di stucco a rilievo che raccordano l’affresco della volta.
Attraverso due porte si accede alla Sala della Cappella che conserva alcuni arazzi della serie della regina Artemisia realizzati dalla Manifattura di Parigi, Boulevard St. Marcel e datati ai primi anni del XVII secolo.
Interessanti anche i dipinti, tra cui spicca la Resurrezione di Cristo e di alcuni esponenti della famiglia Colonna alla fine dei tempi di Pietro da Cortona. Presenti in sala anche L’Angelo Custode e il Mosé con le tavole della legge del Guercino. Da notare infine il lampadario, il più grande del palazzo, realizzato a Murano nel XVIII secolo.
All’interno della piccola cappella di famiglia si trovano, sopra l’altare, il crocifisso ligneo di Giuliano da Sangallo e una Sacra Famiglia di Giuseppe Bartolomeo Chiari, mentre sulla destra, una Deposizione di Paolo Farinati (XVI secolo). Sulla sinistra, la vetrata del XIX secolo raffigurante la traslazione del corpo della Beata Margherita Colonna da Castel San Pietro alla chiesa romana di San Silvestro in Capite (1283).
Riattraversando la Sala Gialla, si passa all’attigua Sala dei Primitivi. Qui è conservato un maestoso arazzo francese dei primi del ‘600, anch’esso di manifattura parigina – Boulevard St. Marcel – raffigurante La Regina Artemisia che assiste alla lezione di equitazione di suo figlio Lygdamis. La sala ospita inoltre una notevole collezione di dipinti, prevalentemente a soggetto sacro, collocabili tra il XV e il XVII secolo. Tra i tanti, due piccole tavole del celebre artista ferrarese Cosmè Tura raffiguranti rispettivamente La Madonna col Bambino (detta anche Madonna dello Zodiaco per i segni zodiacali raffigurati sullo sfondo) e La Vergine annunciata; il Sant’Agostino di Carlo Crivelli, la Madonna con Bambino e Santi di Jacopo Palma il Giovane, i due dipinti di Pietro Alemanno con Sant’Antonio Abate e un Santo Vescovo, i due Bernardino di Mariotto con L’Adorazione dei pastori e Cristo fra i dottori, le due piccole tavole, dipinte dal cosiddetto Maestro della Predella Colonna, raffiguranti La Nascita della Vergine e Due Donatori inginocchiati in un paesaggio.
Le pregevoli tappezzerie iberiche “all’indiana” della metà del XVII secolo adornano le pareti della successiva Sala dei Ricami, tessute con la tecnica del filo d’oro e seta. Il baldacchino centrale riporta gli stemmi Colonna e Pamphilj, ricordando così le nozze tra Filippo II, figlio primogenito di Lorenzo Onofrio e Maria Mancini Mazzarino, e Olimpia Pamphilj, avvenuto nel 1697.
Da questa sala si accede ad un piccolo vestibolo, con pareti di specchi, affrescato nella metà del XVIII secolo, che ci ricollega alla Sala dell’Apoteosi di Martino V.
Palazzo Colonna
L’edificazione delle varie ali di Palazzo Colonna si è protratta per cinque secoli e ciò ha comportato la sovrapposizione di diversi stili architettonici, esterni ed interni, che lo caratterizzano e rispecchiano le diverse epoche di appartenenza.
Dal 1300 al 1500 si presentava come una vera e propria fortezza di famiglia. Oddone Colonna, eletto papa l’ 11 novembre 1417 e assunto il nome di Martino V, destina il Palazzo a Sede Pontificia e vi abita dal 1420 al 1431, anno della morte.
Nelle Sale austere di Palazzo Colonna, Papa Martino V pianifica e realizza in dieci anni un grande piano di rinascita culturale, urbana e amministrativa della città di Roma, che giaceva in condizioni rovinose dopo il tormentato periodo della cattività avignonese e dello scisma d’ occidente.
Nel 1527, durante il sacco di Roma ad opera delle truppe dell’ Imperatore CarloV, Palazzo Colonna è tra i pochi edifici che non vengono dati alle fiamme grazie ai buoni rapporti della famiglia con l’ Impero, ma offre un rifugio sicuro ad oltre tremila cittadini romani.
Nel corso del 1600, il Palazzo assume la veste di un grande palazzo barocco per volere di tre generazioni di famiglia, i cui principali esponenti sono Filippo I, il Cardinale Girolamo I e Lorenzo Onofrio, che si affidano ad architetti e artisti di grande competenza e notorietà.
Prestano infatti la loro consulenza Gian Lorenzo Bernini, Antonio del Grande, Carlo Fontana, Paolo Schor e molti altri.
Di quest’ epoca è anche la costruzione della splendida e maestosa Galleria Colonna, che si affaccia per 76 metri su Via IV novembre; autentico gioiello del barocco romano, è oggi visitabile al pubblico, con gli appartamenti più rappresentativi e di maggior pregio artistico del Palazzo, che ospitano le Collezioni Artistiche di famiglia, notificate e vincolate dal fidecommisso del 1800, ove si possono ammirare capolavori di eccellenza assoluta ad opera dei maggiori artisti italiani e stranieri tra il XV e il XVI secolo.
Tra i tanti, Pinturicchio, Cosmè Tura, Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Salvator Rosa, Bronzino, Guercino, Veronese, Vanvitelli e molti altri ancora.
Appartamento Principessa Isabelle
Qui è possibile ritrovare la stessa atmosfera raccolta, la stessa cura nei dettagli e l’ attenzione a non spostare le foto di famiglia, accanto alla celebre collezione che raccoglie ben trentasette vedute di Vanvitelli.
E non è l’ unico primato di questi ambienti, che si trovano nel piano terreno del palazzo sorto sulle fondamenta dell’ antico Tempio di Serapide.
Una delle poche tracce del santuario romano è un coccodrillo in porfido, che accoglie il visitatore all’ inizio di quella sequenza di saloni dove si sono alternati
celebri artisti come il Pinturicchio, il Pomarancio e il Cavalier Tempesta.
Il pavimento dell’ appartamento è solo in parte quello antico “ alla veneziana “, visibile nella Sala della Fontana; in tutti gli altri saloni, infatti, la Principessa ha sostituito il rivestimento tradizionale con il lucente marmo orientale, ispirata forse dalle sue origini libanesi.
Isabelle Colonna, nata Sursock, famiglia di origine bizantina stabilitasi in Libano dal diciassettesimo secolo, si innamorò del Principe Marcantonio, che la portò in Italia, dove seppe inserirsi con successo nella società romana, all’ epoca alle prese con l’ ascesa di Mussolini.
“ Gran dama di corte, intelligente, colta, conservatrice nel senso più puro e coerente, dopo la caduta della monarchia si era trovata a sostituire Maria Josè come “ regina supplente “, offrendo ricevimenti regali, cui erano ammesse unicamente teste coronate e fra i borghesi soltanto finanzieri e banchieri, purché, ovviamente, non fossero divorziati “ ( così la ricorda Laura Laurenzi sul quotidiano la Repubblica del 18 novembre 1984, in occasione del suo funerale ).
Negli ultimi anni di vita il suo appartamento si era trasformato in uno scrigno di tesori, che amava mostrare soltanto agli amici più intimi.
Al muro ancora è visibile il baldacchino con il simbolo di famiglia, al centro delle stanze si trova la consolle in legno dorato dove Turchi incatenati ricordano la celebre battaglia di Lepanto del 1571, con cui Marcantonio Colonna fermò la minaccia dell’ invasione musulmana.
Uno dei pezzi più rari è l’ orologio notturno dipinto, custodito tra due bauli all’antica nella Sala della Fontana: all’ interno un meccanismo silenzioso muove i numeri retro-illuminati da una candela.
Poco più in là, uno strano divanetto doppio, che gli esperti chiamano “confidenza“, ricorda i numerosi incontri che devono essersi consumati tra queste mura per oltre seicento anni.
In questi salotti aleggia ancora la presenza di altre due celebri donne di famiglia: Maria Mancini, di cui è conservato il ritratto ad opera di Simon Vouet, pittore alla corte di Luigi XIV di Francia, e Olimpia Pamphilj, evocata dalle colombe col ramo d’ ulivo dipinte sui soffitti dei primi saloni dell’ appartamento.
La prima, nipote del potente Cardinale Mazzarino, raccontò nei suoi diari le disavventure della sua infelice relazione con Lorenzo Onofrio Colonna, da cui era fuggita. Per ottenere il suo rientro a Roma, lui le chiuse le porte di tutti i salotti d’ Europa.
Triste epilogo di una relazione iniziata sotto i migliori auspici, come dimostra il soffitto dipinto da Giacinto Gimignani, in cui si assiste all’ incontro tra una colonna antica e una coppia di pesci, simbolo araldico dei Mancini.
Eppure per un certo periodo Lorenzo Onofrio e Maria devono essere stati felici: Maratta e Dughet li hanno addirittura ritratti nelle vesti di Venere e Paride, come forse spesso si erano mostrati nei famosi balli in costume che amavano organizzare.
Nella parete accanto al loro doppio ritratto “ in costume “, Jan Brueghel il Vecchio ha lasciato nove piccoli paesaggi fantastici ,dipinti su rame per far risaltare il calore dei rossi e il nitore cristallino degli azzurri.
Solo un altro dei tanti tesori nascosti in questa dimora, che rivela come spesso si possa convivere tranquillamente a contatto con assoluti capolavori.
Tutti i sabati dalle 9,00 alle 13,15 con ingresso da Via della Pilotta, 17.
2-3 ore
Libri e Guide
No products were found matching your selection.
Merchandise
No products were found matching your selection.
Musei correlati
A partire da €10,00
Tempio del cinema in Italia dal 1937, anno della sua fondazione, Cinecittà coniuga l’attività di polo di produzione e realizzazione di opere cinematografiche con quella di struttura espositivo-museale in continuo ampliamento dal 2011. Entrando dallo storico ingresso razionalista di via Tuscolana e proseguendo nell’area verde del parco, i visitatori sono accolti da elementi scenici come il Cavallo a Dondolo di Pinocchio e la misteriosa testa della Venusia, realizzata per il film Il Casanova di Federico Fellini del 1976. L’esperienza di visita include i percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra e del MIAC Museo italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.
Tempo medio di percorrenza:
2-3 ore
A partire da € 7,00
La Galleria si trova al primo piano di un’ala seicentesca del Palazzo appartenuto al cardinale Girolamo Capodiferro (1502-1559), che la fece costruire su edifici preesistenti di proprietà della famiglia dall’architetto Bartolomeo Baronino di Casale Monferrato.
Tempo medio di percorrenza:
1 ora
Aperto alla fine del 2019 negli Studi di Cinecittà, all’interno di un edificio storico nato negli anni Trenta come laboratorio di sviluppo e stampa e deposito pellicole, il MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema è un museo multimediale, interattivo e immersivo dedicato all’arte delle immagini in movimento, per raccontarne la storia e l’evoluzione tra il XX e il XXI secolo, dalle origini del cinema fino all’arrivo della televisione e alle nuove tecnologie digitali.
Tempo medio di percorrenza:
1-2 ore